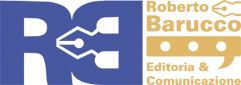Questa sera l’estate d’un tempo è un ricordo struggente. Quasi fisico. Ne risento profumi e rumori. Risate e leggerezza. Voglia di vivere.
Così rispolvero questo breve racconto:
– La sella “normale”, no. Per carità. L’ultimo sussulto degli anni Settanta, giusto a cavallo dell’era del riflusso e dell’edonismo reaganiano, vuole la “sella lunga”. La ricordate, ragazzi dai capelli grigi non più sciolti al vento, del tempo che il casco l’avevano “solo i veci” (attenzione, ogni bipede sui trenta era vecio) o chi girava con la “moto” quella vera? Per intenderci, il “350” 4 cilindri, anzi “354” dal manubrio basso con lo specchietto, a volte due? O con il “nove”, tanto per stare in clima di Novecento, di cilindrata, però, oltre che di secolo.
Brivido dell’accelerazione, altro che cafè racer, scarico “4 in 1”, massima fiducia, quando arriva lo stop in fondo alla via, nei freni.
Ma questi sono i divertimenti dei “grandi”, roba dai trenta in su, si diceva. Gente in sella a bolidi appena sognati e intravisti sui vialoni, più che altro, “ascoltati” passare, riconosciuti dal rombo.
Chi pieno, chi altissimo, chi ultracompresso.
“Geppo” sta arrivando? No, non senti il risucchio in aspirazione. E, via, un suono tra l’aspirapolvere e un gargarismo gracchiante. “Pacio”. “Di sicuro”, la marmitta l’ha sistemata lui.
Noi intanto, ragazzi del motorino dalla sella lunga, ci accontentavamo di cavalcare un mito a due ruote e due pedali, mentre gli eroi del viale ormai quasi trentenni si sfidavano a motori imballati, casco appeso al braccio, occhiali a specchio incollati al viso, primi gel cementiferi a inchiodare i capelli.
Li guardavi sostare. Sigaretta. Appesa all’angolo della bocca, jeans a pelle. Stivaletto totale con cerniera laterale e tacco. Camicia attillata aperta davanti, se possibile, nera. Catena hawaiana di perline a girocollo. I più raffinati, guanti in pelle leggera.
Dietro, quello che oggi sarebbe l’equivalente della “ragazza-zainetto” che vediamo a volte appollaiata su mostri da oltre cento cavalli, sospesa alla speranza che la piega, del centauro sull’ultima curva, non dei capelli, non sia mai sbagliata.
Jeans, scarpe da ginnastica di tela e plastica. O traforate, ricordate?, e felpina: non possiamo dire il brand, ma allora, era di gran moda. Se possibile, sotto, niente reggiseno. Che la frenata dopo la prova dell’accelerometro possa lasciare, speranza manifesta, che le tette esercitino la giusta e libera pressione sulla maglietta, indi la schiena, infine sugli ormoni.
Beh, dicevamo, perdonate le digressioni su chi aveva più anni, noi eravamo spettatori delle altrui prodezze, abbandonati al manubrio del nostro ciclomotore con sella lunga. Sella che, comprata a caro prezzo, aveva uno scopo preciso. Caricare, a nostra volta, la sospirata fanciulla, badate bene, siamo nella fascia dei quattordici, quindici anni di allora, diversa, concedetecelo, dai, da quella dei quindicenni always on contemporanei.
Eccoci, all’epoca: jeans (marca ben nota), che dovevano scolorire nell’uso e nel vissuto, vero, non a colpi di candeggina. Voleva dire vivere all’interno di queste brache. Con relativo ammorbidimento, da stoffa nuova a tessuto a trazione integrale. Un paio di jeans, due. Che erano la nostra divisa. D’estate più leggeri. Tutto lì.
Scarpette da ginnastica traforate, come dicevo prima. Non so perché, ma ci fu un periodo che esaltò l’epopea del piede scalzo a calzare tela incrociata e plastica. Piede che, a fine giornata estiva, non aveva l’aspetto e la fragranza di una rosa.
Camiciona, infilata nei suddetti jeans e rimborsata a valle di una cintura con qualche borchia. O vagante all’aria, fuori dai pantaloni. Se il viaggio era impegnativo, giubbino. Di jeans, per cambiare. Con pelo interno bianco d’inverno e senza pelo, come noi, del resto, imberbi quattordicenni, d’estate impegnati a cantare Tozzi, Baglioni, Zero.
Il casco? Purtroppo, è una vergogna ammettiamolo, non era parte del nostro lessico. Manco un berretto. Che sarebbe volato via. Il camicione in compenso aveva (confidavamo nel potere taumaturgico di simili amuleti), sul retro, ovvero sulla schiena sempre alla ricerca di contatti senologici da frenata (come per i ‘vecchietti’ delle moto), immagini di soggetti che suonavano la chitarra, allontanandosi verso orizzonti infiniti, foglie di cannabis (inutile negarlo, c’erano anche quelle), scritte tipo “enjoy” e via discorrendo. E un certo campionario grafico di cantanti in voga all’epoca.
In caso di calore intenso, estivo, non fraintendete, ciabatte infradito in cuoio grezzo, con relativo alluce infernale violetto e pulsante dopo poco, destinate a lanci estemporanei in frenata.
Era così, più o meno così, che un gruppo di noi che eravamo quelli del quartiere, si gettava, accompagnato da magici camicioni e amuleti al collo, capelli al vento (li avevamo, davvero, li avevamo tutti e pure lunghi, come indiani metropolitani, non sorridete, amici della tribù delle lunghe stempiature) e pedalate, o spinte, d’avvio.
Sì, perché il ciclomotore, sottolineo il passaggio, ciclo-motore, partiva a pedalata. Altro che batteria, avviamento elettrico, satellite e mappe e gps e prese usb.
Sul cavalletto, per chi l’aveva, rapida pedalata in stile Gran Premio della Montagna, “decompressore” tirato, c’era anche quello e scoppiettava che era un piacere, e via!
Il motore si accendeva, il cavalletto scivolava in avanti, la ruota posteriore prendeva e tamponavi l’amico ancora fermo.
Era così che si muoveva il branco, a zig-zag, prima di prendere forma, consistenza e, a presa di coscienza avvenuta, direzione definitiva.
Sul motorino da tempo ci avevamo messo le mani tutti, nel gruppo. Era così: sella lunga, bianca, di solito, che faceva figo, magari lavorata, in fintissima pelle. Acceleratore con “il rapido”, che lo faceva salire di giri in fretta, senza slogarsi un polso nel giro completo, pedali… Beh. I pedali erano necessari, ma non troppo.
L’elaborazione da strada prevedeva la loro rimozione. Come un veicolo in doppia fila. Meno peso. Si viaggiava senza pedali. Partenza a spinta con risalita a bordo “alla bersagliera”. Faticoso? Sì. Ma volete mettere l’effettone sulle fanciulle che guardavano di sottecchi il nostro gesto atletico?
Infine, ma meriterebbe pagine a parte, per parsimoniosi risparmi e attese pazienti, il motore. Due gli aspetti. Chi poteva cambiava la marmitta. A espansione, con il “chiusino” che se no i Vigili ti bastonavano. O senza, a tuo rischio. Potenza e casino, soprattutto casino, in più. E puleggia piccola, per guadagnare allungo.
Sull’accelerazione, stendiamo un velo pietoso. Infine, ecco il capitolo risparmio, chi aveva qualche lira (che bello citarla ancora, come una vecchia amica che rispunta all’improvviso), accumulata tra Natale e Pasqua, la spendeva nel “sessanta”: cioè l’elaborazione che l’amico più esperto di motori “ci pensava lui”. A parole, perché all’atto pratico lui era peggio di noi e con risultati altrettanto pessimi, ma con le mani sporche d’olio, a simboleggiare familiarità e simpatia con il ciclo a due tempi.
Era davvero così, e così erano i “mostri”, ci parevano tali, che si avviavano in formazioni da caccia compatte lungo le vie del quartiere. Ci sentivano arrivare, come le prime piogge d’agosto, torrenziali e improvvise, e sparire in lontananza, come una libecciata di fine settembre.
Giravamo finché benzina (costava seicento lire al litro) e ombre della sera lo permettevano, inseguendo l’estate. E i nostri sogni, e quel tratto diviso con una ragazza dai seni sodi, appena vagheggiati sotto una maglietta, invocando la frenata che avrebbe esaltato i nostri ormoni compressi, la carezza del vento, il canto delle cicale. Care, amiche cicale, libere, meravigliose e spensierate -.